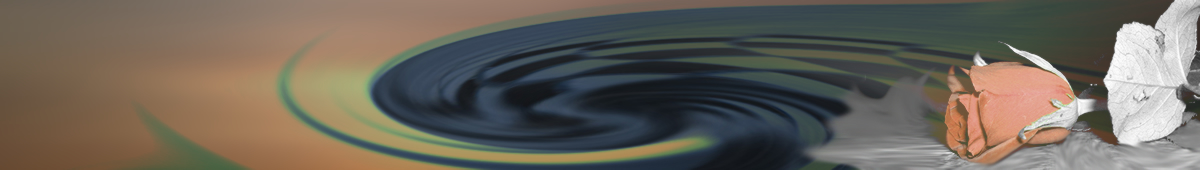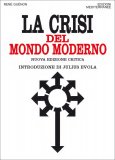di Daria Cozzi
In quella magnifica giornata di sole, Elsa guardava con dolcezza Teresa, che giocava con gli altri bimbi della sua età. Era serena.

Sapeva di aver fatto la cosa giusta e provava in fondo, nelle viscere, in quello spazio dove nascono le emozioni e dove una volta albergava l’angoscia e la disperazione, una sorta di avvolgente riconoscenza, non sapeva verso chi o che cosa ma sapeva che finalmente si sentiva la vita pulsare dentro l’anima.
Veniva ogni giorno al giardino. Veniva e andava, con i suoi figli, senza paura. E poi se ne tornava a casa con la luce nel cuore.
Era passato un anno da quando se n’era andata via da Trieste. Era seduta da un bel po’ su quella panchina con Francesco in grembo che aveva smesso di ciucciare e si era addormentato sul suo seno ancora scoperto. Non voleva muoversi, Elsa, per non interrompere quel momento così intenso e pieno di amore.
Ne aveva fatta di strada in quell’anno. E finalmente poteva ripercorrere con la mente quel suo travaglio senza esserne annientata. Anzi, ora le sembrava proprio indispensabile andare indietro nel tempo, per ricordare, per riflettere, per nutrire quel suo senso così forte e così ben radicato dentro di sé di essere una donna finalmente libera e capace di andare avanti a testa alta. Perché ciò che ha fatto male, non si deve dimenticare. Mai.
Ricordava tutto come in un film. La donna in divisa le aveva detto che ci avrebbe messo cinque minuti. Non di più. E che aveva già avvisato che sarebbe arrivata. Eppure a Elsa quei cinque minuti parevano dieci. O forse anche venti.
Forse era la bora che soffiava così forte, quel giorno, che la rallentava. O forse quelle scarpe che aveva indossato in fretta, prima di andarsene. Non le avrebbe mai messe se avesse potuto scegliere. Sapeva che le facevano male, ma non c’era tempo quel giorno. Bisognava fare in fretta. Sentiva dentro un fremito così violento che fare presto era un imperativo. Così aveva preso la bambina in braccio, i documenti, cinquanta euro e aveva infilato le prime scarpe che aveva trovato.
In quei trecento metri la sua vita le si era srotolata nella mente come una pergamena su cui stavano incisi con il sangue quei momenti che non voleva dimenticare. Si, avrebbe voluto, una volta, ma non ora. Non più.
Aveva cercato di resistere per tanto tempo, aveva pensato che tutto si sarebbe sistemato se solo lei avesse saputo essere più comprensiva, se avesse lasciato perdere, se avesse fatto finta di nulla, se fosse riuscita ad ingoiare le offese e le pedate, gli schiaffi e le minacce. In fondo, che cos’altro avrebbe potuto fare? Dove sarebbe potuta andare? E poi, chi mai le avrebbe creduto?
Un giorno che aveva tentato di reagire lui le aveva urlato che era una lurida puttana, che se avesse parlato con qualcuno avrebbe fatto la figura della pazza e che le avrebbero tolto la bambina. Che l’avrebbero affidata a lui. Che nessun avvocato l’avrebbe presa come cliente. “Tra colleghi – diceva sarcastico – non ci si fa la guerra”.
Lei lo sapeva che lui era più forte, più scaltro, più abile, che aveva tanti amici, che godeva di stima e di rispetto e che non sarebbe stato facile mettersi contro. Così Elsa se ne era stata zitta per anni. Cercava di ritagliare qualche momento di serenità quando andava da sua madre. Ma neanche a lei aveva raccontato il suo inferno. Si vergognava. E anche di fronte agli altri aveva imparato a sorridere.
Va tutto bene. Tutto bene.
Nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Temeva che gli altri potessero accorgersi delle sue fragilità e poi si sentiva tremendamente in colpa. Pensava che forse tutto quello che le stava capitando se lo meritava. Perché non era stata capace di essere una brava moglie e neanche una brava madre. Non aveva saputo mantenere la sua indipendenza, difendere i suoi valori, proteggere la sua bambina.
In quei momenti, quando lui incominciava ad alzare la voce e i suoi occhi veicolavano quello sguardo così feroce, lei sapeva bene come e cosa sarebbe successo. Rimaneva paralizzata dal terrore. Pensava che restare ferma, immobile, lo potesse calmare. Muta rimaneva, per non provocarlo, per non infastidirlo ulteriormente, per non dire qualcosa di sbagliato. E quando lui aveva finito di sbraitare, le volte che non la colpiva con pugni e schiaffi, lei era certa che non era andato oltre perché lei aveva saputo stare zitta. Si… non era andato oltre.
Ma quel giorno no. Quel giorno aveva sentito una forza dentro così potente che le aveva fatto decidere che era ora di dire basta. Basta per sempre. Basta per tutti. Basta per lei e per i suoi figli. Per Teresa e per quell’esserino che era poco più che un agglomerato di cellule ma che sarebbe diventato, un giorno, un essere umano. E lo immaginava libero dalla violenza. Da qualsiasi violenza.
Quando glielo ha detto, che era incinta, lui l’aveva presa per il collo, l’aveva sbattuta contro il muro e le aveva urlato che se ne doveva liberare. Subito. Non come l’altra volta che aveva aspettato troppo. E poi le aveva sferrato un calcio nella pancia.
Si era accasciata sul pavimento Elsa, e Teresa era rimasta pietrificata sulla soglia della porta della sua cameretta con il suo orsachiotto di pelouche in mano. Gli occhi pieni di lacrime. La pipì giù per le gambe.
Poi lui se n’era andato, aveva sbattuto la porta urlandole che avrebbe chiamato il suo amico ginecologo che avrebbe fatto il lavoro. Presto. Ecco Elsa e Teresa sole. La bambina aveva lasciato cadere il pelouche nella pozza di urina e si era avvicinata alla madre. Si erano abbracciate ed erano rimaste strette a lungo, senza parlare, perché in quell’abbraccio le parole erano di troppo.
Solo alla fine la piccola, con la semplicità che solo i bambini sanno avere, le aveva sussurrato “mamma, andiamo via” e con quelle sue piccole braccia l’aveva aiutata a rialzarsi. “Si, andiamo” aveva solo detto Elsa. Erano uscite nel giro di cinque minuti. Veloci. Prima che lui potesse tornare. Il tempo di indossare un cappotto e prendere due cose.
Ecco perché in quei cinque minuti di strada doveva ricordare tutto, anche se farlo le squarciava il cuore e le lacrime diventavano ghiaccio sul suo viso, in quella fredda giornata invernale. Doveva ricordare perché ora dentro sentiva ardere il coraggio di una leonessa che difende i suoi cuccioli. Perché non avrebbe più subito tutte le umiliazioni e le botte che l’avevano trasformata in un fantoccio.
Elsa quel giorno aveva deciso di riprendersi la sua dignità di donna e di madre. Di persona.
Aveva deciso di parlare, di raccontare, di chiedere aiuto perché quello che aveva nascosto per anni ora non le faceva più paura. Voleva solo finire, voltare pagina, riprendersi la sua vita. Essere un punto di riferimento sicuro per i suoi figli. Non avrebbe mai voluto per loro una vita così infelice e già era andata troppo oltre.
Con Teresa per mano, perché non ce la faceva a tenerla in braccio ancora, anche se avrebbe voluto per non interrompere quel loro silenzioso patto di aiuto reciproco, aveva arrancato lungo la via del Teatro Romano e poi, passo dopo passo, su per quella lunga scala che porta alla chiesa e poi ancora a destra, verso il Centro Antiviolenza.
L’operatrice l’aveva accolta con un grande sorriso. “Sei Elsa, vero? Ci hanno avvisato dalla Questura che saresti arrivata, non ti preoccupare, qui sei al sicuro. Ora ti faccio un the e poi vediamo come possiamo aiutarti, va bene?”
Elsa aveva annuito e gli occhi le si erano subito riempiti di lacrime che inondavano il suo viso. Lacrime di commozione e di gratitudine. Le sembrava un miracolo che qualcuno le avesse detto quelle parole, le sembrava impossibile non sentirsi in colpa, le sembrava una grazia essere ascoltata e creduta.
E l’avevano aiutata. “Ti manderemo in un centro di un’altra città dove potrai stare tranquilla e portare a termine la tua gravidanza. Poi penseremo a cosa fare”.
Seduta su quella panchina Elsa aveva capito da dove era ripartita la sua vita. Da quegli occhioni terrorizzati eppure così pieni d’amore e di consapevolezza, da quelle piccole braccia che l’avevano aiutata a rialzarsi. Grazie piccola mia.
Ora va tutto bene. Davvero.
Questo racconto è stato selezionato per la pubblicazione nel volume di racconti del XII Concorso Internazionale di Scrittura Femminile “Città di Trieste”
Articolo di Daria Cozzi
Fonte: http://www.lundici.it/2016/04/va-tutto-bene/